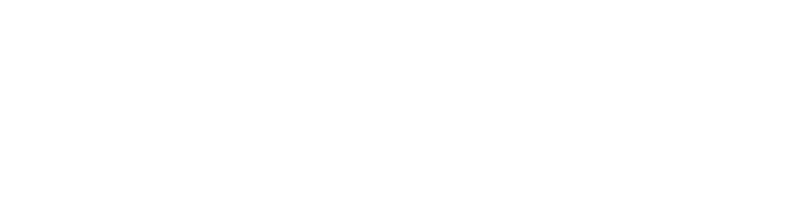L’Ulisse di Dante, eroe ancora attuale per molti ragazzi
In una società che pare dominata dall’apparire più che dall’essere, in un mondo in cui i valori autentici sembrano obsoleti e in una realtà contemporanea che mostra e diffonde solo i brutti esempi c’è un nutrito numero di persone che non aderisce a ciò che risulterebbe in linea coi tempi che corrono ma coltiva altri interessi.
Fanno meno rumore questi individui ma ci sono, e non sono soltanto i “dotti dinosauri” delle polverose aule universitarie, anzi, sono proprio i giovani ad aver sete di conoscenza e non sono nemmeno in pochi.
Spesso additati come i responsabili del degrado generale, gli esponenti delle nuove generazioni sono i primi a ribellarsi alla deriva della cultura e del suo fascino.
Un esempio viene proprio dal tanto criminalizzato social network Tik Tok, a dimostrazione che il problema non è mai il mezzo di espressione e comunicazione ma l’uso che se ne fa.
Edoardo Prati, anche ospite alla trasmissione “Che tempo che fa” su Nove è stato definito il ‘Barbero di TikTok‘.
Il ragazzo, divenuto ormai un noto personaggio televisivo, ha circa 472.000 follower su Instagram e oltre 210.000 su TikTok dove è divenuto celebre per i suoi contenuti sulla letteratura classica.
Nei suoi video il ventunenne riminese tocca argomenti come le emozioni, l’amore e il significato dell’esistenza, interpretando in maniera semplice le opere letterarie del passato dimostrando come esse possano essere immortali.

E Prati non è l’unico giovanotto giunto alle luci della ribalta grazie alla sua passione per la letteratura, è solo il più noto tra i giovanissimi Ulisse che, ancora nel terzo millennio, sono mossi dalla voglia di divulgare il sapere spingendo i compagni a varcare le “Colonne d’Ercole” che limitano l’uomo al rango di bestia.
L’itacese è ancora eroe per chi tra intelligenza artificiale e capi firmati ha voglia di gridare a gran voce che “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” [Dante, Inf. vv 118-120]

Lo scrisse Dante Alighieri nella sua Commedìa diversi secoli fa facendolo pronunciare al suo personaggio di Ulisse che sottolineava come la nostra umana natura ci porti ad aver sempre sete di conoscenza.
È questo per Dante che ci distingue dalle bestie.
È un appello contro l’imbarbarimento dell’essere umano.
Siamo al verso 119 del Canto XXVI dell’Inferno, noto ai più proprio come il “Canto di Ulisse” che ne è assoluto epicentro.
Egli è stato punito a causa delle sue astute ma ingannevoli azioni, ecco perché è uno dei consiglieri fraudolenti, collocati nell’ottava bolgia dell’ottavo cerchio.
La colpa di Ulisse non è solo quella di aver ideato l’inganno del Cavallo di Troia ma, soprattutto, quella d’aver sfidato i limiti imposti dalla volontà divina per la sua inesauribile sete di conoscenza.
È questo che lo ha portato a compiere il “Folle volo” come lo ha definito il professor Raffaele Giglio, docente ordinario di Letteratura italiana dal lontano 1994 alla Facoltà di Lettere della “Federico II” dove ha svolto la sua attività di ricerca e di didattica che lo hanno portato a diverse pubblicazioni. Tra esse spicca, appunto, la monografia “Il volo di Ulisse e di Dante. Altri studi sulla “Commedia”. È in questo testo che appare la metafora delle ali e del volo che l’eroe greco spicca verso la conoscenza quando decide di varcare lo stretto tra la Rocca di Gibilterra e un promontorio della città di Ceuta dove il Mar Mediterraneo sfocia nell’Oceano Atlantico e dove gli antichi avevano posto i confini invalicabili del mondo degli uomini. La storia, rievocata da Dante nella Divina Commedia, affonda le sue antichissime radici nel mito del semidio Eracle che pose due colonne come segno tangibile oltre il quale vi erano l’ignoto ed il proibito. Fin dai tempi più remoti, filosofi, pensatori e scrittori hanno ipotizzato cosa potesse esserci oltre quel limite. Per Platone, per esempio, oltre quel punto si doveva trovare la leggendaria isola di Atlantide; per Dante, invece, si ergeva il monte del Purgatorio che Ulisse riesce a intravedere prima di essere colpito insieme ai suoi compagni da un turbine divino che lo porta alla morte e all’eterna condanna ad ardere negli inferi in una fiamma a due punte insieme al suo inseparabile compagno Diomede. Tutto questo intreccio di mitologia greca, cultura cristiana e poesia, che è alla base dell’opera dantesca, fa emergere un eroe intramontabile e senza tempo, l’Ulisse dantesco rivive nel cuore di tutti coloro che non si adagiano nel conforto di ciò che è noto e rasserenante ma che sono pronti a spiccare il volo verso nuovi orizzonti, anelando perennemente il sapere e le nuove conoscenze, come è nell’umana natura che sprona l’uomo a migliorarsi e a migliorare cose e persone che lo circondano così come fanno i ragazzi, curiosi di sapere ed esplorare nuovi terreni anche se non lo comunicano agli altri coi mezzi d’un secolo passato ma con smartfone e tablet, ali dei loro voli oltre nuove colonne.
Articolo a cura di
Francesco Di Somma