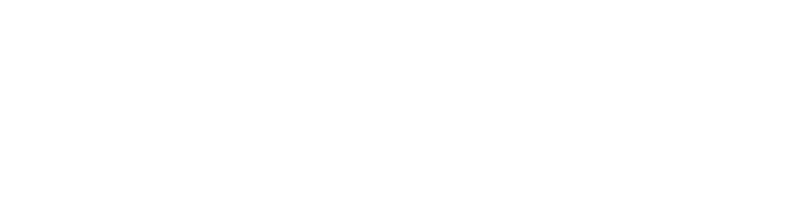“La società della neve”, cannibalismo, tra morale e spirito di sopravvivenza
Il disastro aereo delle Ande fu un famoso incidente aereo che coinvolse il volo 571 delle Forze Aeree Uruguaiane. L’episodio di cronaca riguardò un charter partito da Montevideo il 13 ottobre 1972 e diretto a Santiago del Cile. L’aereo precipitò sulle montagne con 45 persone a bordo fra passeggeri e membri dell’equipaggio, inclusi 19 giocatori della squadra di rugby dell’Old Christians Club, le loro famiglie e gli amici. Tale vicenda, che fece molto scalpore, è stata raccontata in quattro film, dei quali, l’ultimo in ordine cronologico, è del 2023 ed è attualmente disponibile su Netflix. Il titolo è “La società della neve” ed è significativo perché il racconto è incentrato proprio sulla comunità che si venne a creare tra i sopravvissuti. I precari equilibri istauratisi in un gruppo umano, involontariamente e forzatamente, insediatosi in uno dei luoghi più inospitali del pianeta sono il tema principale della storia. Il regista è Juan Antonio García Bayona per una produzione che coinvolge Spagna, Uruguay e Cile che ha guadagnato vari premi e alcune candidature agli Oscar. Gli spunti di riflessioni sono tanti perché, nonostante le mille avversità, ben sedici persone riuscirono nel miracoloso intento di tornare a casa. Il prezzo da pagare fu, però, altissimo. Il dramma, infatti, non fu solo umano e fisico ma anche morale ed ideologico. Nella narrazione, dopo la morte di molti nello schianto, inizia, infatti, la disavventura vera e propria; bisogna sopravvivere a temperature glaciali che giungono anche a trenta gradi sotto lo zero con pochissimi viveri, feriti e il terrore di non essere più rintracciabili. I giorni passano fino a quando un evento ancora più devastante colpisce la comunità: una valanga travolge il relitto del veivolo, usato come riparo, mentre i ragazzi dormono, uccidendo altre otto persone e seppellendo il resto del gruppo sotto la neve. Per ore si lotta per uscire e respirare. Questo evento riduce drasticamente il numero dei sopravvissuti e li porta al limite della disperazione. Bisogna, logicamente mangiare per non cedere. Con il passare delle settimane, senza nessun segnale di soccorso e con il cibo esaurito, ci si trova di fronte ad una decisione impensabile: nutrirsi dei corpi dei compagni morti per sopravvivere. È un momento straziante ma la fame e la consapevolezza che con l’aumento del gelo le ricerche sono ormai interrotte spinge i giovani a farlo. Inizialmente alcuni sono riluttanti, si rifiutano, ma poi tutti accettano questa crudele necessità. Tentativi di ritrovare la coda dell’aereo falliscono, così come quelli di ripristinare contatti radio. Dopo oltre due mesi, i ragazzi si rendono conto che l’unica speranza è mandare qualcuno a cercare aiuto. Nando Parrado e Roberto Canessa partono per un viaggio estenuante attraverso le montagne, portando solo pochi rifornimenti e vestiti improvvisati. Dopo dieci giorni di cammino, ormai allo stremo, incontrano un contadino cileno dall’altra parte delle Ande. Le autorità organizzano rapidamente un’operazione di soccorso. I primi elicotteri raggiungono il luogo dello schianto il 22 dicembre 1972, più di due mesi dopo l’incidente. I sopravvissuti tornano a casa, accolti come eroi. La decisione di nutrirsi dei compagni morti diventò oggetto di dibattito pubblico negli anni Settanta ma il coraggio e la forza d’animo di quelle persone resta, ad oggi, un vero e proprio simbolo delle capacità di adattamento umane. Il film è, quindi, meritevole di visione, non solo per conoscere nel dettaglio l’evento storico, narrato con minuziositá di dettagli, ma soprattutto per vivere emozioni fortissime provando a calarsi in quel contesto estremo interrogandosi su se stessi, il senso della vita e quali siano le cose che in essa contino effettivamente.
Articolo a cura di
Francesco Di Somma