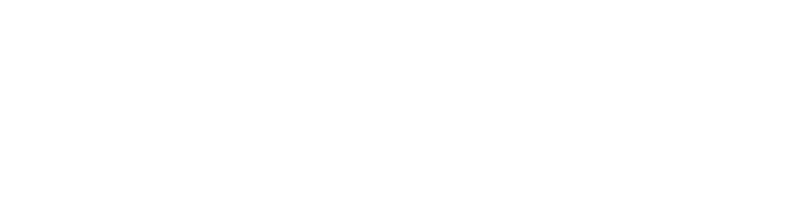Vesuvio, proprio oggi sono ottantun’anni di riposo dal 1944
La Seconda guerra mondiale, la cacciata dei tedeschi e l’arrivo delle truppe angloamericane scuotevano gli animi del popolo di Napoli al punto tale che, addirittura la terra partenopea sembrò ribellarsi a cotanta violenza. Proprio nella giornata odierna, 18 marzo, si contano ottantuno anni dall’ultima eruzione del Vesuvio. Era il 1944, il conflitto bellico entrava nella sua fase più devastante per l’Italia, spaccata in due e letteralmente alle prese con una guerra civile. Quel giorno a tutto ciò s’aggiunse un’esplosione che distrusse parzialmente il piccolo cono di scorie intracraterico del vulcano campano. Il tutto fu documentato con filmati al punto tale che si sa con precisione che essa fu subito seguita dall’emissione di due separate colate laviche dal cratere, una in direzione Sud-Est e l’altra in direzione Nord per poi essere deviata dal Monte Somma in direzione Ovest. Il 19 marzo l’attività esplosiva ed effusiva si fecero più intense e la lava si diresse verso le cittadine di San Sebastiano e Massa che, alle prime ore del 21, furono invase dalla lava. Tempestivamente le truppe Alleate avevano organizzato, poco prima, l’evacuazione di circa 7000 abitanti. Giuseppe Imbò, geofisico e sismologo procidano, studiò e raccontò tutto il processo. Sappiamo, quindi, che avvenne poi una nuova fase esplosiva stromboliana con spettacolari fontane di lava, l’ultima delle quali durò ben cinque ore. Le ceneri arrivarono fino all’Agro Nocerino-Sarnese. La deposizione di materiale di colore scuro causò 23 vittime a causa del collasso di tetti per il peso della cenere. Da quel giorno non si sono verificate più eruzioni e il Vesuvio è considerato quiescente ossia temporaneamente in stato di riposo o di inattività. Volgendo lo sguardo al passato si scopre che gli storici ritengano che già 400.000 anni fa la zona del Vesuvio sia stata soggetta ad attività vulcanica, tuttavia sembra che la montagna abbia iniziato a formarsi 30.000 anni fa, probabilmente come vulcano sottomarino nel Golfo di Napoli; emersa successivamente come isola, si unì alla terraferma per l’accumulo dei materiali eiettati. Da allora numerose eruzioni ed esplosioni caratterizzarono quell’area; esse sono state dettagliatamente classificate dagli esperti con le denominazioni di Pomici di Codola, Pomici di Base, a seguito della quale si formò il monte Somma, Pomici Verdoline, Pomici di Mercato e Pomici di Avellino. Tutte queste eruzioni, per la loro immane violenza, e perché simili a quella che avrebbe poi distrutto Ercolano, Pompei, Oplontis e Stabia, sono chiamate eruzioni pliniane, dai nomi di Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, studiosi romani, testimoni diretti dell’eruzione del 79 d.C., durante la quale il primo morì e il secondo raccontò l’evento che fu successivo ad una lunga fase di riposo. Per molti secoli, infatti, scrittori antichi descrissero questo tranquillo monte coperto di orti e vigne, eccetto per l’arido culmine. L’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. mutò parecchio la morfologia del vulcano e dei territori circostanti. Nei secoli a venire il Vesuvio eruttò circa 36 volte fino al 1631, anno di un’altra imponente eruzione, legata al culto di San Gennaro. Le reliquie e la testa del santo vennero portate in processione fino al ponte della Maddalena per chiedere al Patrono di Napoli di proteggere la città. L’eruzione del 1906 venne raccontata da Matilde Serao, ad essa fece seguito quella del 1929, quando nel cratere si creò un lago di lava, che traboccò sul versante Sud-Est e distrusse solo alcuni vigneti per poi giungere all’ultimo grande evento in ordine cronologico del quale oggi possiamo scaramanticamente festeggiare un simbolico “compleanno” augurando al Vesuvio un sereno riposo ancor lungo e tranquillo.
Articolo a cura di
Francesco Di Somma